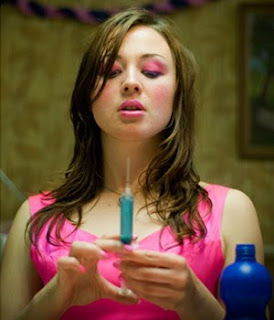The Town
Boston. Doug MacRay è un rapinatore di banche in una realtà dove la criminalità è considerata quasi un mestiere che si tramanda di padre di figlio. Durante uno degli ultimi colpi, la sua banda rapisce Claire Keesey, direttrice della banca, e poi la lascia andare appena raggiunta una zona isolata. Preoccupato che la donna possa comunque aver scoperto l’identità dei suoi rapitori, Doug decide di incontrarla “in borghese”: in questo modo fra i due nasce però una relazione in cui Doug vede la possibilità di affrancarsi dalla vita in cui è prigioniero.
A dispetto della sua linearità narrativa che si rifà alla grande tradizione del gangster-movie americano (non a caso alle spalle c’è ancora la Warner Bros), The Town è un film di contrasti che determinano una realtà magmatica, capace di favorire emozioni tra loro molto diverse. Ecco dunque che Ben Affleck, qui alla sua seconda regia, si permette di chiamare in causa un film apparentemente distantissimo come Gomorra (fra le dichiarate, seppur labili, fonti d’ispirazione) per cercare una chiave di volta che gli permetta di raccontare una storia di uomini che vuole essere innanzitutto ritratto di una città.
La Town del titolo è Boston, che non si limita quindi ad essere semplicemente lo sfondo della vicenda, ma diventa il tramite e la causa delle emozioni che il racconto veicola: segnato da un legame parentale con il crimine (il padre in prigione), Doug MacRay è uno dei principali artefici del clima che si respira in città, ma non è possibile distinguere pienamente il suo ruolo fra quello del criminale puro e quello invece della persona che si ritrova coinvolta in un meccanismo più grande di lui, che finisce perciò per determinarne il destino. L’uomo è infatti un rapinatore speciale, perfettamente a suo agio nel realizzare i colpi, ma è allo stesso tempo attratto dalle altre possibilità offerte da una realtà dove una giovane e affascinante donna come Claire Keesey ricopre il ruolo di direttore di banca.
Seguendo un andamento molto classico, ma declinato rispetto alle contraddizioni del presente, Doug è dunque un uomo stretto tra forze convergenti, fra il bisogno di una microcomunità che dipende dalla sua bravura e ne determina perciò la natura stanziale, e un mondo esterno che chiama con la promessa di vivere una vita differente e più realizzata: il personaggio di Claire, apparentemente strumentale a determinare unicamente la sua “conversione”, è in realtà un’interessante figura salvifica che innesta elementi quasi mitologici nel cuore della vicenda. A tal proposito risulta estremamente intelligente la scena dell’attrice Rebecca Hall, che sta costruendosi un bel percorso come compagna di volta in volta di personalità
borderline che in lei trovano la chiave di volta delle proprie vite, l’elemento di salvezza o la testimonianza della loro dannazione (pensiamo a
Frost/Nixon o a
The Prestige). Doug appare quindi più che altro inserito in un meccanismo inerziale dove il suo agire è dettato dalle circostanze: non in senso morale (dacché egli è sicuramente ben presente rispetto al suo ruolo nella società e alle sue implicazioni), ma emotivo. Rapinare una banca per Doug è onorare un legame affettivo con chi è venuto prima di lui e con chi gli sta affianco.
In questo senso, la realtà si rivela fondata su un sovvertimento delle regole canoniche di convivenza, dove l’amore “ingannevole” fra Doug e Claire è l’unico sentimento reale, in un sistema fondato su continue bugie. Anche il rapporto fra Doug e l’amico/fratello Jam, sebbene meno virtuoso, va in questa direzione: i due infatti sembrano perpetuare le rapine come unico possibile codice condivisibile fra due personalità sicuramente legate, ma intimamente troppo diverse. Nel personaggio di Jam, infatti, Jeremy Renner lascia rivivere le pulsioni distruttive del sergente James di
The Hurt Locker: un agire irruento, spesso assolutamente illogico e amorale che però è sempre ben circoscritto all’interno di un oliato meccanismo sentimentale, dove comunque la cooperazione fraterna è sempre vista come primo motore di tutto.
Di concerto arriva il sistema di riferimenti che il film mette in scena, che chiamano spesso in causa la cultura
pop come linguaggio comune fra i personaggi (pensiamo alle maschere che si ispirano dichiaratamente allo Skeletor di
Masters of the Universe), ma che spesso giocano anch’essi con le aspettative dello spettatore sovvertendo il concetto di iconografia classicamente inteso. Ecco dunque che i travestimenti dei rapinatori fanno appello anche a figure completamente opposte a quelle comunemente associate al crimine (suore, poliziotti), mentre la polizia agisce nell’ombra, intessendo nuovi inganni, visti come unica possibile soluzione per catturare il ladro.
La città, solcata nelle sue strade, esplorata dall’alto è il teatro di tutto questo, un luogo, come già rimarcato, attivo, solido, concreto nei suoi giochi cromatici, “usato” dalla gente, manipolato e attraversato fisicamente, in un modo che sembra una continua comunione con i suoi spazi, dove vige quasi una logica dei vasi comunicanti per cui il mandante dei colpi è anche l’apparentemente mite fioraio: la regia di Affleck riesce ottimamente a esprimere i continui stati d’animo che personaggi e luoghi vogliono trasmettere e, nonostante una certa preferenza per i risvolti più romantici, riesce a rendere congrui i paragoni che sono stati mossi con il cinema di John Frankenheimer.
Resta più sullo sfondo la monolitica figura dell’agente federale Adam Frawley, che, chiuso nella sua ossessione e incapace di aprirsi alla vita, appare meno combattuto e “poroso” del protagonista e perciò più distaccato dai sentimenti dello spettatore. Il suo personaggio, insomma, si determina proprio in quanto elemento altero rispetto alla città e ai suoi contrasti: una ennesima figura di contrasto, dunque.
The Town
(id.)
Regia: Ben Affleck
Sceneggiatura: Peter Craig, Ben Affleck e Aaron Stockard, dal libro Il principe dei ladri, di Chuck Hogan
Origine: Usa, 2010
Durata: 125’